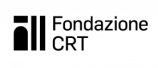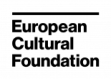Il 2 ottobre 1968 si spegneva a Neuilly-sur-Seine, uno degli artisti che hanno rivoluzionato l’arte del Novecento: Marcel Duchamp. La genialità di Duchamp è stata quella di spostare il baricentro dal fare al pensare l’arte.
Le sue opere più famose, infatti, non sono quadri ma oggetti, atti, perfino scelte. Se davanti a un dipinto, a una scultura o a un oggetto comune ci poniamo la questione “è arte?”, lo dobbiamo in parte anche a lui.
Duchamp è un vero e proprio nume tutelare per chi si occupa di contemporaneità. Con la sua opera è riuscito a scardinare l’idea di arte tradizionale, aprendo la strada ai linguaggi concettuali del Novecento.
- Parigi 1904, la nascita dell’avanguardia
- Nudo che scende le scale: gli esordi di Duchamp
- La svolta concettuale: un orinatoio diventa arte
- Quando gli oggetti comuni diventano arte: il ready-made
- La Gioconda con i baffi: come dissacrare capolavori intoccabili
- L’eredità di Duchamp, da Andy Warhol a Banksy
Parigi 1904, la nascita dell’avanguardia
Duchamp nasce nel 1889 in Normandia, a Blainville-Crevon, in una famiglia borghese di artisti. Due suoi fratelli, Jacques Villon e Raymond Duchamp-Villon, saranno anch’essi protagonisti delle avanguardie.
Cresce in un ambiente colto e aperto alla sperimentazione. Ben presto esprime la volontà di spostarsi nella capitale, dove arriva nel 1904. In quell’anno Parigi è in fermento. Gli atelier, le gallerie e i caffè sono il fulcro d’incontro di pittori, scultori, scrittori e musicisti. Il terreno è fertile affinché il XIX secolo ceda il passo all’avanguardia del Novecento.
Il 1904, a tal proposito, è un anno simbolico. Nel 1904, infatti, Henri Matisse dipinge Lusso, calma e voluttà. Un’opera-manifesto, esposta al Salon d’Automne del 1905, che dà vita alla corrente del Fauvismo. Il nome (fauves = “belve”) fu coniato in senso ironico da un critico, colpito dall’uso libero, soggettivo, a tratti violento del colore. Nei quadri dei fauves, le tinte pure e intense non descrivono più la realtà, ma sono specchio delle emozioni dell’artista davanti ad essa. Insomma, nel 1904 si prepara la rivoluzione cromatica che esploderà l’anno successivo.
Nel 1904, inoltre, Pablo Picasso si trasferisce in pianta stabile a Parigi, organizzando un atelier a Montmartre. L’artista è nella fase di passaggio dal periodo blu al periodo rosa. Utilizzando anche lui il colore in maniera soggettiva, raffigura temi circensi e figure leggere. Un preludio al Cubismo.
Nudo che scende le scale: gli esordi di Duchamp
Marcel Duchamp risente del fermento che permea Parigi a inizio Novecento. Le sue prime opere sono, infatti, ispirate proprio al Cubismo e al Fauvismo. Ma già nel 1912, la sua carriera prende una svolta più originale. In quell’anno a Parigi viene organizzata una mostra destinata a fare scuola. Per la prima volta, nella capitale, vengono mostrati i lavori dei pittori futuristi italiani. Oltre trenta opere di Boccioni, Severini, Russolo e Carrà aprono a Parigi uno scenario fino ad allora inedito.
L’esaltazione della velocità, del dinamismo, della modernità – in contrasto con l’arte tradizionale – e la rappresentazione del movimento e della simultaneità attraverso linee-forza e forme scomposte colpiscono Duchamp. Proprio nel 1912, il pittore presenta l’opera Nudo che scende le scale n. 2. Qui unisce dinamismo futurista e scomposizione cubista, destando scandalo. L’opera, che raffigura una figura umana in movimento, come se fosse una sequenza cinematografica, viene rifiutata per il suo carattere troppo “meccanico” e “offensivo”. Il giovane artista capisce così che il suo cammino sarà in conflitto con le istituzioni artistiche tradizionali.
La svolta concettuale: un orinatoio diventa arte
Ben presto la carriera parigina di Duchamp è destinata a interrompersi. Lo scoppio della Prima guerra mondiale costringe, infatti, l’artista a emigrare negli Stati Uniti nel 1915. A New York, due anni dopo il suo arrivo, Duchamp compie uno dei gesti più radicali e provocatori della storia dell’arte contemporanea.
Entrato in un negozio di sanitari, acquista un comune orinatoio in porcellana bianca. Lo rovescia, lo firma con lo pseudonimo “R. Mutt” e lo presenta, con il titolo Fontana, all’esposizione annuale della Society of Independent Artists. L’associazione proclamava di accettare qualsiasi opera dietro pagamento della quota di iscrizione. Nessuna giuria, nessuna selezione. Ma davanti a questo oggetto quotidiano, semplicemente spostato di contesto e ridefinito come scultura, i membri del comitato – di cui lo stesso Duchamp faceva parte – decidono di non esporlo.
Quel rifiuto, paradossale e clamoroso, diventa l’innesco di una rivoluzione. Duchamp non aveva fatto un’opera nel senso tradizionale, ma aveva scelto un oggetto e lo aveva proposto come arte. Il gesto di Duchamp dà vita a una serie di questioni destinate a cambiare per sempre il mondo dell’arte: chi decide che cosa è arte? È sufficiente la firma di un artista per rendere arte un comune oggetto? Trasformare un orinatoio in una fontana – quindi cambiare il significato di qualcosa – è un gesto artistico? Il fatto stesso che l’orinatoio sollevi queste domande lo rende degno di un interesse?
Quando gli oggetti comuni diventano arte: il ready-made
Nasce così, di fatto, il concetto di ready-made. Oggetti di uso comune che, isolati e messi in un contesto espositivo, diventano veicolo di un’idea piuttosto che di una perizia tecnica. Con Fontana, l’attenzione si sposta dalla manualità alla scelta e al concetto.
L’orinatoio originale, probabilmente distrutto, non è sopravvissuto fino ai nostri giorni, ma l’opera vive attraverso fotografie, testimonianze e repliche autorizzate dallo stesso Duchamp negli anni successivi, come quella del Centre Pompidou di Parigi.
Oggi Fontana è considerata un simbolo della rottura con l’estetica ottocentesca e una delle pietre miliari dell’arte concettuale. Con quell’oggetto, Duchamp ha dimostrato che l’arte poteva essere soprattutto un atto mentale. Fontana sposta l’attenzione dal valore estetico al valore concettuale. Non importa come un oggetto è fatto, ma che cosa significa la sua scelta.
La Gioconda con i baffi: come dissacrare capolavori intoccabili
Dopo aver dissacrato e superato la tradizione artistica precedente, Duchamp continua la sua rivoluzione. Se un qualunque oggetto quotidiano può essere arte, allora che senso ha celebrare, con spirito quasi religioso, i capolavori del passato? Essi sono e restano capolavori, ma chi ha detto che non possano essere ripensati, decostruiti, sporcati?
E allora, perché non prendere il mito assoluto, la Gioconda di Leonardo da Vinci, e dissacrarlo? L.H.O.O.Q. (1919, New York, collezione privata) è una cartolina della Monna Lisa a cui Duchamp aggiunge baffi e pizzetto, accompagnata da un titolo che, letto in francese, suona come elle a chaud au cul (“lei ha caldo al sedere”).
Un gesto ironico e provocatorio diventa esso stesso arte. È un atto che anticipa le strategie della Pop Art e del postmoderno, dove le immagini vengono citate, moltiplicate, manipolate.
L’eredità di Duchamp, da Andy Warhol a Banksy
Duchamp non ha solo provocato o creato oggetti strani. Ha cambiato per sempre il senso stesso dell’arte e le domande che ci pone un’opera d’arte. Se prima di Duchamp era sufficiente recarsi davanti a un quadro o a una scultura e ammirarne la bellezza o la perizia tecnica, dopo Duchamp la riflessione si fa più complessa. L’arte diventa un’idea, un processo, un contesto.
Artisti come Andy Warhol, Piero Manzoni, Joseph Beuys, Maurizio Cattelan o Banksy devono a lui la possibilità di trasformare azioni, oggetti e immagini quotidiane in opere cariche di significato. Persino il gesto di firmare o reinterpretare un oggetto iconico – dalla zuppa Campbell’s di Warhol alla Madonna con la pistola di Banksy – ha radici duchampiane.
A più di un secolo dai suoi ready-made, Duchamp continua a essere un punto di riferimento per chi vede nell’arte non solo estetica, ma pensiero critico, ironia e libertà. In questo senso, è il vero artista del futuro: colui che ha insegnato che, a volte, per creare basta… scegliere!