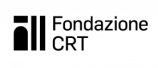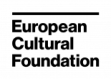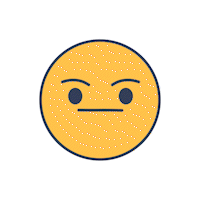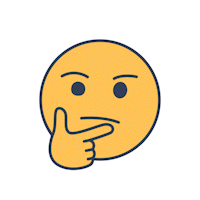Great Freedom di Sebastian Meise | Ode all'amore paradossale nella Germania del dopoguerra
Runtime
Ambientato nella Germania Ovest post-bellica, Great Freedom (Große Freiheit) è un film drammatico a tematica queer, una storia di persecuzione che reinventa i canoni del film carcerario. Per allontanarsi dal tipico arco narrativo della fuga fisica, il film volge lo sguardo all’interno e mostra le forme della sopravvivenza dell’identità contro l’oppressione spietata. Anziché ridurre la vita alla violenza, la prigione diventa il luogo in cui l’intimità si trasforma in realtà con uno sfarfallio tenace. Con la sua sobria intensità e il focus sulla dignità prima ancora della liberazione, il film richiama Hunger (2008) di Steve McQueen, in cui la resistenza diventa un atto di sfida.
Con il regista e sceneggiatore austriaco Sebastian Meise alla guida, Great Freedom riunisce due icone del cinema tedesco: Franz Rogowski e Georg Friederich. Il secondo, stella nascente del cinema europeo, ha dato probabilmente il meglio di sé in questa performance, cementando la propria reputazione internazionale. Il film durante il 74° Festival di Cannes (2020) ha vinto il premio Un Certain Regard ed è stato nominato per la Palma Queer.
- Uno sguardo queer sulle ingiustizie del dopoguerra
- Il corpo come ribellione: il desiderio come atto di resistenza
- Le ombre della legge: il paragrafo 175 e la libertà negata
- La sovranità del desiderio: l’amore come paradosso nel film
Uno sguardo queer sulle ingiustizie del dopoguerra
Great Freedom offre una prospettiva alternativa sulla Germania Ovest post-bellica. Per minoranze come la comunità queer, il passaggio dal nazismo al liberalismo non è stato un momento di progresso perché la repressione è continuata con altri mezzi. Il Paragrafo 175, la legge che puniva l’omosessualità, è infatti rimasto in vigore e veniva applicato in modo ancora più stringente.
In questo contesto storico, per primo incontriamo Hans (Franz Rogowski). Appena liberato da un campo di concentramento, si ritrova nuovamente incarcerato per lo stesso motivo: un desiderio definito criminale. Il primo compagno di cella, Viktor (Georg Friedrich), è un uomo con un passato misterioso che ha atteggiamenti completamente omofobi nei suoi confronti. Il cinismo di Viktor all’inizio sembra il riflesso nitido del clima politico del momento, fino a quando non gli consiglia di coprire il numero identificativo che ha tatuato sull’avambraccio. Mostra anche uno dei suoi tatuaggi ad Hans, definendolo un errore di gioventù coperto in modo simile. La forma originale non è facile da distinguere, né viene nominata esplicitamente – sarà stato un pene?
È una scena fondamentale, perché racchiude lo sviluppo della loro relazione. Sotto la superficie, Hans e Viktor condividono un dolore comune e un’identità repressa che li lega. Il passaggio del tempo, rappresentato non tanto dalle date ma con il trucco, diventa eloquente. Grazie al lavoro meticoloso di Heiko Schmidt, Roman Braunhofer e Kerstin Gaecklein, il tempo diventa materiale, un fardello di sofferenza che si incide nei volti e nelle azioni dei personaggi. Lo spazio invece rimane atemporale, quasi non cambia: è un carcere. La regia sobria di Meise, con riprese lunghe e calme, riflette il senso di stagnazione e rende palpabile il passaggio strascicante del tempo, rendendo epocale anche il cambiamento più piccolo.
Il corpo come ribellione: il desiderio come atto di resistenza
La repressione è sempre una forma di disciplina. All’interno dei confini della prigione, in una piccola cella, il corpo è forzato ad avere una routine designata a normarlo. Il sistema separa, sorveglia e punisce pur di eradicare la devianza. Il corpo di Hans, in particolare, deve essere purificato perché è visto come macchiato da un desiderio di “inversione”. Deve quindi essere raddrizzato sopprimendo qualsiasi forma di espressione.
Ma il desiderio è il motore della vita e reprimerlo vuol dire uccidere la vitalità della persona. Hans lo sa, anche se non lo esplicita. La notevole performance di Rogowski è costruita intorno a questo principio. Il suo personaggio si trova in un campo minato da attraversare per rimanere vivo. Se il suo desiderio venisse scoperto, la sua condanna verrebbe prolungata, se rimanesse taciuto lui crollerebbe e il suo mondo interiore morirebbe. L’equilibrio è delicato, proprio come le sue scelte attoriali. Hans è un personaggio introspettivo: non parla molto e sembra sempre concentrato sulla propria interiorità, come se non volesse perdere la traccia del proprio desiderio. Allo stesso tempo, i suoi gesti sembrano misurati e soffocati dalla violenza.
Anche se costantemente esposto alle forze dell’oppressione, Hans resiste. Attraverso trucchi e sotterfugi riesce ad agire la legge del suo desiderio, ricordandoci che resistere a un sistema discriminante vuol dire non collaborare. E anche se Hans sembra emaciato, la voce è esitante, non significa che stia perdendo. Il suo corpo resta sempre in rivolta, indomito.

Le ombre della legge: il paragrafo 175 e la libertà negata
Hans cerca di stringere legami sentimentali con altri carcerati, ma ogni volta qualcosa interrompe questi tentativi. Cambiano gli amanti, ma la legge che regge le relazioni di Hans rimane invariata. Se Great Freedom fosse un film convenzionale, la fine della storia coinciderebbe con l’abolizione del paragrafo 175 o col suicidio del protagonista, ma il copione di Sebastian Meise e Thomas Reider è capace di giocare con le aspettative che crea nel pubblico, dimostrando tutto il loro virtuosismo.
Per la maggior parte del film, il copione suggerisce un concetto di libertà molto semplice, enfatizzando l’aspetto legale di libertà dalle persecuzioni. Una libertà che può essere concessa o meno per legge. Se si guarda però al titolo, si nota che l’aggettivo precede il sostantivo. Questo suggerisce che forse esistono due tipi di libertà: quella semplice, senza aggettivi, e una più importante.
La sovranità del desiderio: l’amore come paradosso nel film
Per questo motivo, quando un film convenzionale finirebbe – con l’ottenimento o la perdita della libertà nel suo senso strettamente politico – Great Freedom svolta e aggiunge profondità ed eleva il significato ad un altro livello. Il nocciolo è una reinterpretazione del dilemma centrale alle tragedie greche: cosa succede quando la legge dell’anima – la legge non scritta del desiderio – entra in conflitto con la legge della città, le leggi sancite dalla società? In questa nuova versione, il dilemma si acuisce esattamente quando ci si aspetterebbe la risoluzione.
Verso la fine del film, il cambiamento nella legge della città – il Paragrafo 175 – anziché rimuovere l’ostacolo ne crea uno nuovo, diventando la causa della liberazione di Hans. Il suo amore, paradossalmente, va oltre la semplice libertà, sia letteralmente che figurativamente. È ancora incarcerato e si chiama Victor. Per seguire la più alta legge del desiderio, Hans deve violare di nuovo la legge della città a discapito della virtù ritrovata. Great Freedom essenzialmente è questo: un paradosso romantico.
Tag
Buy a ☕ for Hypercritic