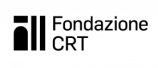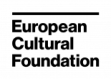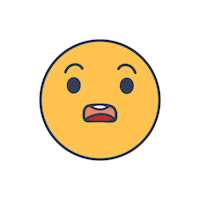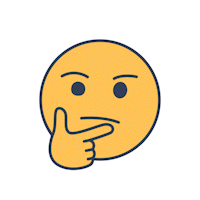Lost (2004-2010) | Vent’anni dopo, significato e impatto della serie tv
Seasons
Runtime
Un occhio si spalanca all’improvviso. Un uomo si risveglia in una foresta tropicale, ma i rumori della natura vengono presto sostituiti dalle urla strazianti di chi è sopravvissuto a un incidente aereo. Le scene si susseguono una dopo l’altra fino alla fine dell’episodio pilota, che si conclude con una domanda, posta da uno dei personaggi: “Dove siamo?” Come ha ricordato di recente uno degli autori, questa battuta finale doveva trasmettere le sensazioni provate dallo spettatore e impostare il tono misterioso che avrebbe caratterizzato tutta la serie. Lost andava in onda per la prima volta.
La serie, prodotta da ABC, è il risultato di una scrittura a sei mani: Damon Lindelof, J.J. Abrams e Jeffrey Lieber. Si tratta di una storia che intreccia passato, presente e futuro di un gruppo di sopravvissuti a un incidente aereo. I protagonisti si ritrovano su un’isola sconosciuta e cercano di capire come tornare a casa. Nel 2004 – all’alba di una nuova era, dominata dallo streaming e dai social media – c’erano altre serie famose, come I soprano, X-Files e Twin Peaks. Ma grazie alla combinazione di sottogeneri, linee temporali non lineari e personaggi complessi, Lost è diventato il primo vero fenomeno mainstream della televisione.
La serie apre a dubbi su temi esistenziali come il bene e il male, presenza e assenza, vita e morte, razionalità e impulso. Rivela le sfaccettature dell’essere umano in modo complesso ma accessibile. Vent’anni dopo, Lost continua ad attrarre generazioni di spettatori e a sollevare domande e curiosità. Ancora nel 2024, è uscito su Netflix il docufilm Getting LOST.
Una storia di sopravvivenza nella natura e nel mistero
L’aereo di linea 815 della compagnia Oceanic Airlines percorre la tratta Los Angeles-Sydney. Ma durante un viaggio si schianta sulle coste di un’isola misteriosa, nel mezzo del Pacifico. Solo alcune dozzine di persone riescono a salvarsi. Tra loro ci sono Jack Shephard (Matthew Fox), un chirurgo esperto, Kate Austen (Evangeline Lilly), una criminale in fuga, John Locke (Terry O’Quinn), un uomo di mezza età paralizzato, e Sawyer (Josh Holloway), un truffatore spericolato. Presto si rendono conto di essere atterrati in un luogo inesplorato, lontano dalla rotta del volo. Per questo, le speranze di essere recuperati si allontanano.
Il gruppo quindi inizia a organizzarsi per sopravvivere nella natura selvaggia, ma scopre che l’isola nasconde più di quanto sembri. Una presenza mostruosa abbatte alberi al suo passaggio; un segnale radio misterioso interferisce con qualsiasi tentativo di comunicazione e sussurri inquietanti attraversano la vegetazione tropicale. I sopravvissuti si convincono di non essere soli.
Il pubblico aveva già familiarizzato con storie di sopravvivenza su un’isola deserta dal film Cast Away (2000) agli adattamenti di Robinson Crusoe (1719), fino al romanzo Il signore delle mosche (1954). Lost ha rielaborato tutte queste idee, unendole ad altri generi, in una “miscela coinvolgente di azione, fantascienza, suspense, spiritualità e drammi dei personaggi”.
Un nuovo modo di fare serie tv
Apprezzare la portata innovativa di Lost è difficile per il pubblico odierno. Ma nel 2004, i telespettatori hanno capito immediatamente di essere di fronte a qualcosa di nuovo. Da un punto di vista tecnico, tutto, dalla pellicola da 35 mm all’accurato stile di riprese e di regia, richiamava a standard di qualità tipici dei film. Senza menzionare l’ossessionante colonna sonora di Michael Giacchino. D’altronde, il costo stimato per l’episodio pilota si aggira intorno ai 10-14 milioni di dollari.
Inoltre, memore del successo di Twin Peaks di David Lynch e del coevo Desperate Housewives, la serie presenta una trama che si sviluppa senza interruzioni per 6 stagioni. Ogni episodio assume il punto di vista di un personaggio, esplorandone il passato attraverso flashback, flashforward e flash-sideways. Una struttura così intricata e non lineare, in combinazione con misteri sconcertanti e colpi di scena – la frase “Dobbiamo tornare indietro” ricorda qualcosa a coloro che hanno visto la serie? – ha creato il mix perfetto per tenere gli spettatori incollati al divano.
La serie porta i segni di un modo ormai passato di fare TV, quando una stagione era composta da un minimo di 20 episodi e andava in onda ogni settimana per almeno 5 o 6 mesi. Ma la mescolanza di tradizione e innovazione rende Lost un punto di collegamento tra due ere televisive.
Lost e i suoi personaggi corali
Oltre alle comparse, la prima stagione conta su almeno 15 ruoli principali, che andranno costantemente ad aumentare nelle puntate successive. Ogni personaggio incarna idealmente un archetipo dei racconti classici. Su ognuno viene realizzato un approfondimento psicologico attraverso flashback dedicati. Insieme, rappresentano una fetta realistica della vita dei primi anni 2000. Proprio come i personaggi di Sex Education rappresentano l’universo adolescenziale contemporaneo.
Charlie (Dominic Monaghan), dipendente da eroina, è il frontman di un duo rock britannico che ricorda inevitabilmente gli Oasis. Claire (Emilie de Ravin) è una donna incinta, spaventata a morte di essere una madre single. Hurley (Jorge Garcia), un ragazzo solitario, sovrappeso, che diventa ancora più solo dopo aver vinto alla lotteria ed essere diventato milionario. Inoltre, la serie sperimenta introducendo un personaggio iracheno, Sayid (Nour A. Jazeem), solo tre anni dopo l’11 settembre del 2001. Ma anche introducendo una coppia, composta da Jin (Daniel Kae Kim) e Sun (Yunjin Kim), che per quasi tutta la durata della serie parla coreano ed è quindi accompagnata dai sottotitoli.
Una componente stile soap opera non poteva mancare. Anche se lampante e scontato fin dai primissimi episodi, il triangolo amoroso tra Jack, Sawyer e Kate contribuisce alle aspettative. Facendo leva sulla sua trama sfaccettata, Lost ritrae vividamente la “condizione umana e il modo in cui le persone che ci circondano abbiano un ruolo cruciale nelle nostre vite”.
Il dualismo Jack vs Locke
Man mano che la serie va avanti, alcuni personaggi assumono un ruolo prominente rispetto ad altri. È il caso di Jack e Locke, due figure carismatiche che condividono un’indole da leader. Nonostante questo punto in comune, non potrebbero essere più diversi. Jack, essendo un medico, ha un approccio pragmatico e strettamente empirico nei confronti della realtà. Così come suggerisce il suo cognome, Shephard, è nato per guidare gli altri. Al contrario, Locke agisce spesso irrazionalmente e seguendo una visione che trascende dalla realtà materiale. Pensa che il loro aereo si sia schiantato su quell’isola per una ragione: hanno una missione da compiere.
Questo è il mio destino! Non dirmi cosa non posso fare!
John Locke in “La caccia” (Stagione 1, episodio 4)
A causa di questa mentalità così divergente, i due personaggi si scontrano spesso, personificando un dualismo che ha sempre segnato l’azione dell’uomo. Scienza e fede, ragione e cuore, logica e istinto: una dicotomia identificata dal filosofo tedesco Friedrich Nietzsche con le due categorie di apollineo e dionisiaco.
Questa dimensione così filosofica, cui fanno riferimento anche i nomi dei personaggi (Locke, Hume, Rousseau, Linus, Hawking, Faraday), racchiude, secondo l’autore Damon Lindelof, una delle principali ragioni del successo della serie:
Quando si tratta di argomenti come fede e scienza su un meta-livello, non ha importanza ciò che accade nella serie. Quando quest’ultima finisce, tutti questi quesiti continueranno a esistere. Esiste sempre una spiegazione scientifica per tutto ciò che succede nel mondo? Esiste un Dio? La serie non sarà in grado di dare risposte.
Un’isola come metafora universale
Oltre ai personaggi e ai dilemmi filosofici, l’ambientazione rappresenta un punto forte della serie. L’isola dove si ritrovano i passeggeri del volo 815 sembra, fin dai primi episodi, un luogo pieno di misteri e minacce. Addentrandosi nella giungla, i protagonisti innescano un ciclo infinito di enigmi, in cui ogni segreto svelato genera altre domande. Quest’effetto domino, che è stato in seguito adottato da diverse serie (Dark, Sense8 e From, per menzionarne alcune), ha dato vita a un rebus che crea dipendenza. L’effetto collaterale è stato la creazione di una matassa quasi inestricabile per gli sceneggiatori.
Le questioni che rimangono aperte contribuiscono a rafforzare l’immagine dell’isola come uno spazio metaforico, la rappresentazione per antonomasia dell’ignoto e del suo fascino senza tempo per l’uomo. Simboleggia anche l’antitesi della modernità, un luogo che cancella ogni struttura sociale e provoca una regressione a un’economia di sussistenza. Un elemento connette tutti i losties: nella vita quotidiana, si trovavano in difficoltà, intrappolati in relazioni tossiche, in ruoli scomodi o emarginati. L’isola è una seconda occasione, una possibilità di cancellare i loro errori e ricominciare da capo.
Non importa, Kate, chi eravamo, ciò che abbiamo fatto prima di questo, prima dello schianto. Davvero. Tre giorni fa, siamo morti tutti quanti. Dovremmo tutti riuscire a ricominciare da capo.
Jack Shephard in “Tabula Rasa” (Stagione 1, episodio 3)
Ed ecco di nuovo il contrasto tra ragione e fede: l’isola è un luogo infido, ma anche una terra promessa, un mistero spaventoso e al contempo affascinante, un luogo di morte e rinascita.
Il finale che ha diviso i fan
L’impatto di Lost sull’industria televisiva coinvolge non solo la produzione e l’aspetto creativo ma anche il modo in cui gli spettatori erano abituati a vivere le serie tv. L’hype che ha generato è senza precedenti – così tanto che il pubblico non poteva far altro che rimuginare e dibattere per giorni sugli enigmi e colpi di scena della serie, aspettando l’episodio successivo.
Quando internet è entrato nell’uso quotidiano, i social media, blog e forum sono diventati il posto ideale per avanzare teorie e scambiarsi opinioni in tempo reale. Da tutti i punti di vista, si trattava del primo vero fanbase nella piazza virtuale. Nel 2008, un gruppo di fan ha creato una sezione dedicata su Wikipedia, Lostpedia, con più di 7.380 articoli, esplorando tutti gli elementi interni della serie. La ABC ha astutamente incoraggiato questa tendenza implementando una strategia di marketing multipiattaforma. Per esempio, hanno prodotto Lost Experience, un gioco di realtà alternativa che impegnava i fan in una caccia al tesoro virtuale tra blog, pubblicità e video di YouTube.
Così come il finale controverso di Game of Thrones ha scatenato la rivolta di milioni di fan insoddisfatti sui social, l’ultimo episodio di Lost ha diviso il pubblico. Alcuni l’hanno ritenuta una fine perfetta; altri ne hanno criticato l’eccessiva superficialità. A oggi, non c’è un verdetto: un capolavoro assoluto o un’occasione persa? In entrambi i casi, Lost ha lasciato un segno distintivo nella storia televisiva.
Tag
Buy a ☕ for Hypercritic